L’Associazione Coaching Italia definisce il coaching una metodologia che si basa su una relazione di partnership paritaria tra il coach e il suo cliente, che mira a riconoscere, sviluppare e valorizzare le strategie, le procedure e le azioni, utili al raggiungimento di obiettivi operativi collocati nel futuro del cliente.
La relazione con il cliente non è quindi una relazione di aiuto o di sostegno psicologico. Il coach si concentra sulla crescita e lo sviluppo della persona accompagnandola nella definizione di obiettivi raggiungibili, nello sviluppo di consapevolezza, nella creazione di possibilità ed infine nella scelta di un piano di azione che vada nella direzione dell’obiettivo da raggiungere.
Il coach non svolge attività di prevenzione o cura rispetto a malattie o disagi psicologici, non ha un approccio interpretativo, non fa diagnosi di personalità e non fa valutazioni della persona di alcun genere. Il coach non offre soluzioni a disagi esistenziali, non esplora il passato, bensì supporta il cliente a riconoscere i suoi modelli di pensiero e ad attivare tutte le risorse interne per raggiungere l’obiettivo da lui auto-definito.
Inoltre il coach è tenuto a comunicare con chiarezza le differenze tra coaching, counseling, psicoterapia ed altre professioni di supporto e a suggerire al cliente, se necessario, di rivolgersi ad un altro professionista.
Il coaching, al pari di tante altre professioni, non è riconosciuto dallo Stato e, a differenza delle professioni regolamentate, questa è priva di un Ordine professionale.
Non esiste una formazione obbligatoria statale per chi lo esercita professionalmente e lo Stato non ne detta i requisiti minimi per il suo esercizio. Il titolo di coach viene infatti assegnato al termine di percorsi formativi più o meno lunghi, validi e strutturati.
Per questa ragione assumono molta importanza le Associazioni Professionali di Categoria che hanno il ruolo di diffondere e tutelare gli standard etici e professionali del coaching, di fornire una corretta informazione, di riconoscere i percorsi riferiti alla formazione dei professionisti e di rilasciare un “Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi”.
In Italia, oltre a ICF Italia (la filiale italiana di ICF – International Coach Federation) ci sono ad esempio AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) e A.Co.I (Associazione Coachig Italia).
Il counseling non è una forma di terapia (medica psicologica) né di sostegno psicologico.
AssoCounseling definisce l’attività di counseling come: “[…] un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento”.
La S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) definisce il counseling un’attività professionale, basata su abilità comunicative e relazionali, finalizzate a facilitare il cliente nella risoluzione di uno specifico problema o nella presa di decisione. Il cliente può essere identificato nella persona, nella coppia, nella famiglia o nel gruppo. Operativamente il counseling si impegna a favorire la riorganizzazione di capacità, risorse e competenze già possedute dal cliente, facilitandogli un percorso di vita verso obiettivi possibili e realizzabili. Si svolge attraverso colloqui gestiti con le metodologie che caratterizzano la specifica formazione di ciascun professionista che non si pone, in alcun caso, nella posizione di superiorità dell’esperto.
A differenza del paziente nella psicoterapia, il cliente nel counseling è definito “sano” e non ha bisogno di essere curato né aiutato a superare una sofferenza psicologica, ma si avvale delle competenze del counselor come sussidio delle capacità che già possiede in modo da conseguire gli obiettivi che desidera, nei modi e nei tempi che gli sono consoni.
Oggetto del counseling sono difficoltà inerenti un aspetto circoscritto della vita come, ad esempio, lievi e limitati problemi relazionali e interpersonali, orientamento nelle scelte di vita, conflittualità, stress, scelte difficili da intraprendere, sviluppo delle risorse e delle potenzialità.
Il counselor non ha competenze e potere di intervento in tutti quei casi dove sia presente disagio e sofferenza psichica, dolore profondo, disturbi di personalità o altre psicopatologie, che sono di pertinenza del lavoro dello psicoterapeuta.
Anche il counselor è tenuto a comunicare con chiarezza le differenze tra la sua professione e quella di psicologo, psicoterapeuta ed altre professioni di supporto., suggerendo al cliente, se necessario, di rivolgersi ad un altro tipo di professionista.
Anche il counseling, come il coaching, è una professione non organizzata, ovvero priva di una legge istitutiva e di un Ordine Professionale.
Il counsellor deve comunque aver completato uno specifico percorso di formazione di almeno 1000 ore, essere in possesso del diploma abilitante e preferibilmente essere iscritto ad una Associazionie Professionale di Categoria (ad es. AICo; Si.Co; AssoCounseling) che abbia il ruolo di diffondere e tutelare gli standard etici e professionali del counseling.
E’ un laureato in psicologia, che ha svolto un tirocinio formativo obbligatorio e che ha sostenuto e superato l’Esame di Stato che permette l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi.
Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.
La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Lo psicologo esercita anche l’attività di counseling.
A seconda dell’indirizzo formativo seguito durante l’Università lo psicologo possiede diverse competenze che può, dopo la laurea, decidere di approfondire frequentando ulteriori corsi o master.
Lo psicologo può lavorare in diversi ambiti (sociale, clinico, aziendale) purché il suo intervento non si configuri come una vera e propria terapia, per lo svolgimento della quale occorre invece possedere il titolo di psicoterapeuta.
La metodologia di lavoro può prevedere colloqui di consulenza o di sostegno, uso di test, tecniche di rilassamento ma non prevede mai l’utilizzo di farmaci (a meno che lo psicologo in questione non possieda anche una laurea in medicina).
Riassumendo, lo psicologo per essere tale deve possedere i seguenti requisiti:
- laurea in psicologia;
- iscrizione all’Ordine degli Psicologi di una regione italiana.
Lo psicoterapeuta è un professionista autorizzato all’esercizio della psicoterapia dal proprio Ordine Professionale.
Può essere un laureato sia psicologia che in medicina, che abbia però conseguito una specializzazione post universitaria in psicoterapia (della durata di almeno 4 anni) presso una scuola di specializzazione pubblica (universitaria) o privata riconosciuta dal Ministero dell’Università.
Si possono quindi avere:
- psicologi-psicoterapeuti, che possono esercitare tutte le attività dello psicologo e in più la psicoterapia, ma non possono somministrare farmaci.
- medici-psicoterapeuti, che possono esercitare tutte le attività del medico, compresa la prescrizione di farmaci e, in più, la psicoterapia.
L’attività dello psicoterapeuta è quindi più specifica e va più in profondità rispetto a quella dello psicologo, permettendo di intervenire su problematiche più invalidanti e persistenti (depressione, ansia, disturbi alimentari…).
Le tecniche utilizzate variano a seconda del tipo di specializzazione conseguita e, quindi, del modello teorico di riferimento. Le scuole di specializzazione che permettono l’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti sono infatti molteplici e molto diverse fra loro. Ognuna di esse trae origine da un quadro teorico differente ma non necessariamente incompatibile con gli altri, tant’è che spesso gli psicoterapeuti fanno uso contemporaneamente di tecniche provenienti da teorie di fondo diverse.
Tra le scuole di specializzazione più conosciute esistono, ad esempio, quella ad indirizzo cognitivo-comportamentale, quella gestaltica, quella sistemica familiare e quella psicanalitica.
Riassumendo, lo psicoterapeuta per essere tale deve possedere i seguenti requisiti
- laurea in psicologia o in medicina e chirurgia;
- iscrizione all’Ordine degli Psicologi o dei Medici di una regione italiana;
- specializzazione quadriennale post-universitaria in psicoterapia, conseguita presso una scuola di specializzazione riconosciuta dallo Stato;
- iscrizione all’albo degli psicoterapeuti.
Lo psicoanalista è uno psicoterapeuta (medico o psicologo) che esercita un tipo di terapia ispirata alla psicoanalisi di Freud e dei suoi successori.
A partire dalle teorie e dal pensiero di Freud sono nate infatti diverse correnti, definite post-freudiane. Tra queste, ad esempio, ricordiamo la scuola Junghiana basata sulle teorie di Carl Gustav Jung, e quella Adleriana basata sul pensiero di Alfred Adler.
La psicoanalisi, con tutte le sue varianti, è quindi un particolare tipo di psicoterapia.
Riassumendo, lo psicoanalista per essere tale deve possedere i seguenti requisiti:
- laurea in psicologia o in medicina e chirurgia;
- iscrizione all’Ordine degli Psicologi o dei Medici di una regione italiana;
- specializzazione quadriennale post-universitaria in psicoterapia, conseguita presso una scuola di specializzazione riconosciuta dallo Stato;
- iscrizione all’albo degli psicoterapeuti.
Lo psichiatra è un laureato in medicina che ha intrapreso successivamente la specializzazione in psichiatria. Quest’ultima è una disciplina medica focalizzata sulla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi mentali prevalentemente attraverso l’uso di farmaci e psicofarmaci. La psichiatria, a differenza della psicologia, tende generalmente ad identificare il disturbo mentale o psicologico come derivante da un malfunzionamento a livello fisiologico del sistema nervoso centrale.
Lo psichiatra non è psicologo, a meno che non abbia conseguito anche il relativo titolo; può tuttavia esercitare la psicoterapia, ma solo dopo aver conseguito il relativo titolo.
Semplificando, lo psichiatra è più vicino alla figura del medico che non a quella dello psicologo. Accade però frequentemente che lo psicologo/psicoterapeuta e lo psichiatra offrano al il paziente una terapia “combinata”, fornendo contemporaneamente il loro supporto: il farmaco riduce temporaneamente una grave sintomatologia, mentre la psicoterapia permette al paziente di affrontare e risolvere i problemi che hanno causato la patologia, per superarla completamente.
Riassumendo, lo psichiatra per essere tale deve possedere i seguenti requisiti:
- laurea in medicina e chirurgia;
- iscrizione all’Ordine dei Medici di una regione italiana;
- specializzazione post-universitaria in psichiatria.
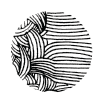

Leave A Comment